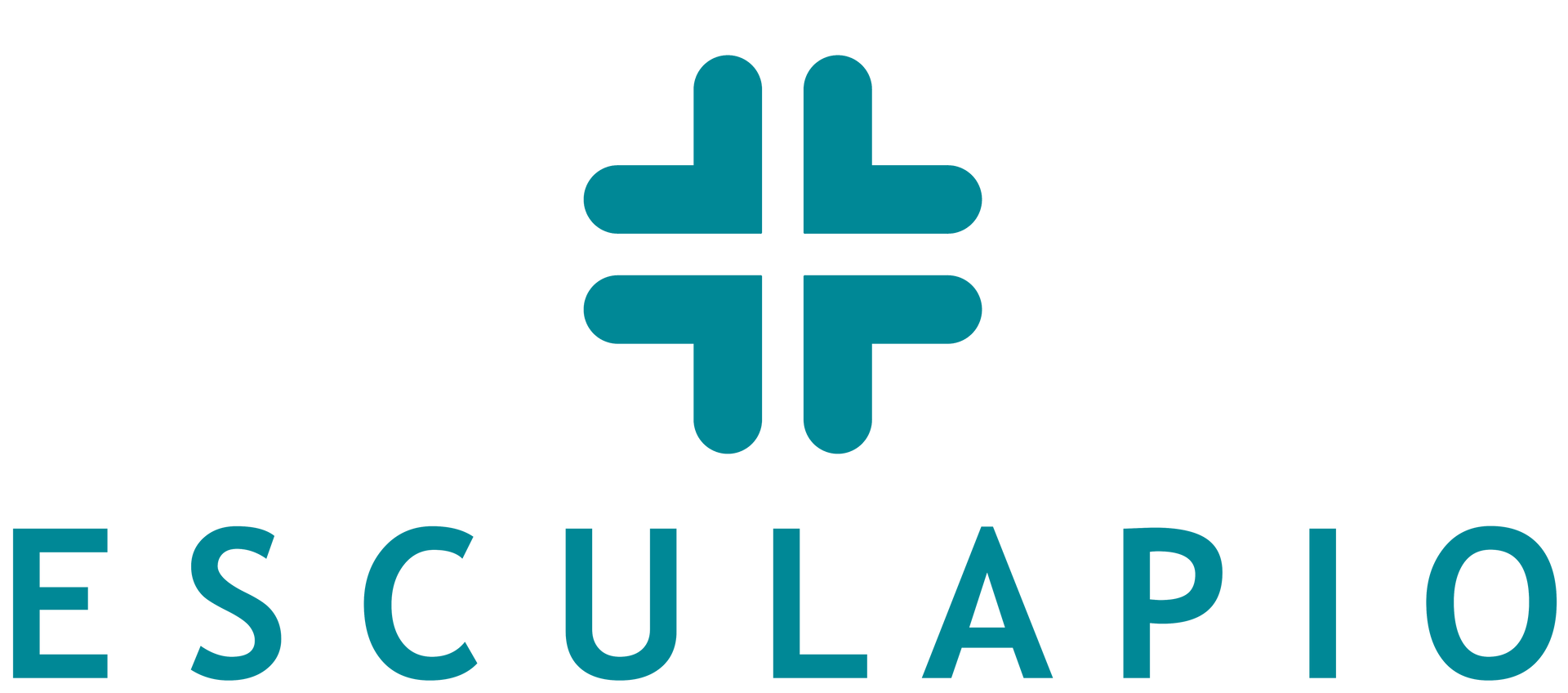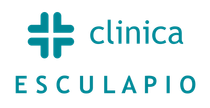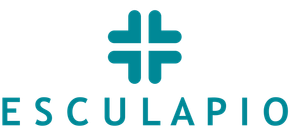CENTRO MEDICO CHIRURGICO ESCULAPIO
CENTRO MEDICO CHIRURGICO ESCULAPIO
Via Giovanni Battista Niccolini, 12 26122 Pisa(PI)
+39 050 830527
CLINICA ESCULAPIO
Loc. Carraia, 1 56017 Ghezzano Pisa (Zona CNR)
+39 050 5383465
Allergologia e immunologia a Pisa
La visita allergologica serve per diagnosticare, monitorare e trattare patologie (respiratorie, cutanee, gastrointestinali, ecc.) di natura allergica; consiste in una dettagliata raccolta anamnestica della sintomatologia del paziente e nella visione di eventuali altri accertamenti già eseguiti dal paziente.
Contestualmente alla visita possono essere eseguiti i test allergologici di primo livello (prick test con allergeni inalanti o alimentari).
Inoltre possono essere programmati, a seconda della sintomatologia riferita dal paziente e sempre su indicazione dello specialista allergologo, ulteriori test di secondo livello, ad esempio test epicutanei (patch test) per la valutazione delle sospette dermatiti allergiche da contatto, e prick-test con alimenti freschi (prick-by-prick) per l’approfondimento di sospette allergie alimentari.
Infine possono essere prescritti, sempre su indicazione dello specialista allergologo, ulteriori esami di approfondimento, es. prelievo ematico per ricerca IgE totali + IgE specifiche, prove di funzionalità respiratoria, ecc.
-
Patologie allergiche trattate
• allergia respiratoria (oculorinite e asma bronchiale)
• allergia alimentare
• patologie dermatologiche di interesse allergologico (es. orticarie acute e croniche, dermatiti allergiche da contatto, dermatite atopica)
• allergia a lattice di gomma naturale
-
Test allergologici eseguiti
• cutireazioni a lettura immediata (prick-test) con allergeni inalanti
• cutireazioni a lettura immediata (prick-test) con allergeni alimentari
• test epicutanei (patch-test)
Come prepararsi alla visita allergologica
I pazienti che devono essere sottoposti a visita allergologica, in previsione dell’eventuale esecuzione delle prove allergologiche (prick-test), devono evitare l’assunzione di farmaci anti-istaminici in qualsiasi formulazione (orale, parenterale, creme, pomate, colliri e spray nasali a base di anti-istaminici) per almeno 7 giorni prima dell’esecuzione della visita stessa.
Prima della visita allergologica non è invece necessario sospendere vaccini per allergia, spray o altre terapie per asma, farmaci cortisonici sia orali che in preparazioni topiche (pomate, creme, ecc.).
Può essere utile portare con sé eventuale documentazione inerente valutazioni allergologiche e /o prove allergologiche precedentemente eseguite.

Titolo diapositiva
Scrivi qui la tua didascaliaPulsante
Titolo diapositiva
Scrivi qui la tua didascaliaPulsante
Titolo diapositiva
Scrivi qui la tua didascaliaPulsante
Che cosa si intende per allergia respiratoria?
L’allergia respiratoria è probabilmente, perlomeno in Italia, la forma più comune di allergia.
Si calcola che la prevalenza dell’allergia respiratoria in Italia sia del 15-20%, ciò significa che il 15-20% circa della popolazione soffre di oculorinite allergica o asma bronchiale o entrambe.
L’asma bronchiale, in particolare, rappresenta un’importante causa di cronicità e di disabilità, e costituisce un importante impatto sui costi socioeconomici.
L’allergia respiratoria rappresenta il “prototipo” delle reazioni allergiche immediate ed è comunemente legata alla produzione, da parte del sistema immunitario, di immunoglobuline (anticorpi) dette IgE e rivolte verso gli allergeni che agiscono per via inalatoria (es. pollini, acari, muffe).
-
Come si manifesta questa allergia?
Le manifestazioni dell’allergia respiratoria possono comprendere oculorinite (prurito e/o bruciore oculare, prurito nasale e starnutazione, ostruzione nasale, ecc.) e asma bronchiale: l’asma bronchiale è molto spesso di natura allergica e si può manifestare con dispnea, tosse secca, respirazione sibilante e sensazione di costrizione toracica, spesso con sintomatologia oculorinitica associata.
-
Quali li allergeni?
I più comuni allergeni inalanti comprendono:
• pollini di piante erbacee (graminacee, parietaria, artemisia, lanciuola, ambrosia)
• pollini di piante arboree (cipresso, nocciolo, betulla, platano, olivo)
• acari della polvere (Dermatophagoides)
• micofiti (muffe) ambientali, ad es. alternaria, cladosporium, aspergillus
• derivati animali (gatto, cane, coniglio, criceto, cavallo, ecc.)
Vi sono poi allergeni inalanti responsabili di allergie professionali, ad es. farine di cereali, polveri di legno, lattice di gomma naturale, ecc.
Gli allergeni pollinici sono responsabili di sintomatologia in genere stagionale, legata al periodo di fioritura della pianta alla quale il Paziente è allergico (es. primavera per le graminacee o le betulle, settembre per l’ambrosia).
Gli acari della polvere, le muffe e i derivati animali sono invece responsabili di sintomatologia cosiddetta persistente, ovvero che si può manifestare tutto l’anno, senza caratteristiche di stagionalità.
Diagnosi dell'allergia respiratoria
- Prick-test: il prick-test (cutireazioni a lettura immediata) è il test diagnostico di primo livello per le allergie respiratorie: si tratta di un test diagnostico molto accurato per la diagnosi delle allergie respiratorie, di rapida esecuzione, economico e sicuro. I prick-test si eseguono praticando attraverso una goccia di estratto allergenico liquido posizionata sulla superficie volare degli avambracci una leggerissima puntura (prick) con una apposita lancetta: per gli allergeni respiratori viene testato un pannello standard di circa 20 allergeni, che comprende quelli più comunemente responsabili di allergia respiratoria; sono poi disponibili ulteriori allergeni da testare in base alle indicazioni del singolo Paziente. La lettura dei risultati viene fatta dopo 15 minuti: se in corrispondenza di un determinato prick dopo 15 minuti compare un pomfo vuole dire che si è sensibilizzati nei confronti di quel determinato allergene. per l’esecuzione dei prick-test bisogna non assumere farmaci anti-istaminici da almeno 7 giorni.
- Ricerca IgE specifiche: la ricerca delle IgE specifiche si esegue con un normale prelievo ematico: consiste nel cercare e dosare le immunoglobuline E (IgE), che sono le responsabili dell’allergia respiratoria, rivolte verso i vari allergeni respiratori. La ricerca delle IgE specifiche rappresenta un test di “secondo” livello, utile quando non è possibile eseguire le prove cutanee (prick-test) o per chiarire dubbi: attualmente è possibile eseguire il dosaggio delle IgE specifiche rivolte non solo verso una miscela di allergeni (ad esempio un polline o un alimento contengono tantissime proteine allergeniche, diverse tra di loro), ma verso una specifica proteina allergenica (cosiddetti allergeni ricombinanti) di quel singolo polline (o alimento): ciò riveste importanti applicazioni nella pratica clinica, come ad esempio la possibilità di orientare con più precisione un’eventuale terapia desensibilizzante (vaccino) nel caso di allergia respiratoria o di “stratificare” il rischio in caso di allergia alimentare (un singolo alimento può contenere diverse proteine allergeniche, e a seconda di quali di queste il Paziente risulta sensibilizzato, sarà diverso il rischio di manifestare reazioni severe in seguito all’ingestione di quell’alimento). I dosaggio delle IgE specifiche rappresenta in ogni caso un’indagine di secondo livello, la cui indicazione deve essere posta dallo specialista allergologo.
Quale la terapia per l'allergia respiratoria?
La terapia delle allergie respiratorie si può avvalere di farmaci anti-istaminici, anti-infiammatori (cortisonici) per via orale o sottoforma di spray nasali o spray per via inalatoria, farmaci ad azione broncodilatatrice (spesso in formulazioni inalatorie per asma in cui vengono associati ai cortisonici); vi sono poi a disposizione farmaci biologici che possono essere utilizzati in alcuni particolari fenotipi di asma grave.
Fondamentale poi la prevenzione, che consiste, quando possibile, nell’allontanamento dell’allergene responsabile, ad esempio misure di “bonifica” ambientale in caso di allergia ad acari o a micofiti.
Infine, nell’allergia respiratoria, una terapia importante e molto efficace è l’immunoterapia specifica (vaccino): consiste nella desensibilizzazione del Paziente allergico attraverso la somministrazione in maniera graduale e costante dell’estratto allergenico in modo che il sistema immunitario riesca a tollerare quel determinato allergene; esiste la possibilità di fare il vaccino per gran parte degli allergeni respiratori.
Sono a disposizione sia vaccini per via orale che per via iniettiva (sottocutanea).
Affinchè risulti pienamente efficace Il vaccino va praticato per un periodo di almeno 3 anni.
Allergia alimentare
-
Che cosa si intende per allergia alimentare?
L’allergia alimentare si manifesta nel 2,5% circa della popolazione generale.
E’ più frequente nei bambini che negli adulti, infatti studi epidemiologici rivelano che tra i bambini con allergie alimentari, circa l’80% raggiunge la tolleranza entro il quinto anno di vita (anche se una parte di loro può eventualmente sviluppare ipersensibilità ad altri alimenti). Come l’allergia respiratoria, anche l’allergia alimentare è molto spesso IgE-mediata.
-
Quali sono i cibi maggiormente responsabili dell'allergia alimentare?
I cibi più comunemente responsabili di allergia alimentare sono:
• frutta fresca, soprattutto mela e prunoidee (pesca, albicocca, ecc.), ma anche banana, kiwi
• frutta a guscio
• sedano
• grano
• arachide
• soia
• senape
• latte
• uovo
• crostacei
• pesce
• semi di sesamo
Ogni alimento contiene una grande quantità di proteine differenti, solo alcune delle quali si comportano come allergeni: tra queste poi alcune hanno una maggiore capacità allergizzante rispetto ad altre.
In base alle loro caratteristiche (stabilità o meno al calore e/o alla digestione peptica, ecc.) queste proteine possono essere raggruppate in classi, ciascuna delle quali può essere responsabile di manifestazioni cliniche differenti.
I più comuni allergeni inalanti comprendono:
• pollini di piante erbacee (graminacee, parietaria, artemisia, lanciuola, ambrosia)
• pollini di piante arboree (cipresso, nocciolo, betulla, platano, olivo)
• acari della polvere (Dermatophagoides)
• micofiti (muffe) ambientali, ad es. alternaria, cladosporium, aspergillus
• derivati animali (gatto, cane, coniglio, criceto, cavallo, ecc.)
Vi sono poi allergeni inalanti responsabili di allergie professionali, ad es. farine di cereali, polveri di legno, lattice di gomma naturale, ecc.
Gli allergeni pollinici sono responsabili di sintomatologia in genere stagionale, legata al periodo di fioritura della pianta alla quale il Paziente è allergico (es. primavera per le graminacee o le betulle, settembre per l’ambrosia).
Gli acari della polvere, le muffe e i derivati animali sono invece responsabili di sintomatologia cosiddetta persistente, ovvero che si può manifestare tutto l’anno, senza caratteristiche di stagionalità.
-
Sintomatologia allergia alimentare
La sintomatologia dell’allergia alimentare è di solito immediata (< un’ora dall’ingestione dell’alimento) e può comprendere diversi quadri clinici, anche a seconda dello specifico allergene alimentare coinvolto; i sintomi di allergia alimentare possono comprendere:
• sindrome orale allergica (ovvero prurito al cavo orale, al palato, alla gola, fino a disfonia e/o sensazione di costrizione alla gola), in genere legata a cross-reattività tra pollini e alimenti vegetali
• manifestazioni cutanee (orticarie acute, angioedema)
• manifestazioni gastrointestinali (dolori addominali, nausea, vomito)
• manifestazioni respiratorie (oculorinite acuta e asma bronchiale)
• manifestazioni anafilattiche (orticaria acuta diffusa, ipotensione arteriosa, sincope, ecc.)
La sintomatologia dell’allergia alimentare può poi comprendere una variabile associazione dei sintomi sopra descritti.
Esiste poi l’anafilassi indotta da esercizio fisico, ovvero scatenata da attività fisica (in genere sportiva) preceduta dall’ingestione di un alimento al quale il Paziente è allergico, ma la cui ingestione a cui non faccia seguito un’attività fisica non sarebbe di per sé sufficiente per scatenare la reazione allergica.
Gli alimenti più frequentemente implicati in questo tipo di reazione sono la frutta secca, i crostacei, il grano, il pesce, alcuni tipi di frutta fresca.
-
Diagnosi allergia alimentare
• Anamnesi: la diagnosi di allergia alimentare non può prescindere da un’accurata anamnesi.
• Prick-test: il prick-test (cutireazioni a lettura immediata) è il test diagnostico di primo livello per le allergie alimentari: si tratta di un test diagnostico di rapida esecuzione, economico e sicuro.
I prick-test si eseguono praticando attraverso una goccia di estratto allergenico liquido posizionata sulla superficie volare degli avambracci una leggerissima puntura (prick) con una apposita lancetta: per gli allergeni alimentari viene testato un pannello standard di circa 25 allergeni; sono poi disponibili ulteriori allergeni da testare in base alle indicazioni del singolo Paziente.
La lettura dei risultati viene fatta dopo 15 minuti: se in corrispondenza di un determinato prick dopo 15 minuti compare un pomfo vuole dire che si è sensibilizzati nei confronti di quel determinato allergene.
Per l’esecuzione dei prick-test bisogna non assumere farmaci anti-istaminici da almeno 7 giorni.
-
Trattamento allergia alimentare
Attualmente il trattamento dell’allergia alimentare si basa soprattutto sull’esclusione dell’alimento o degli alimenti a cui il Paziente risulta allergico, e sul ricorso ai farmaci di emergenza in caso di reazione avversa (anti-istaminici, cortisonici, broncodilatatori, adrenalina autoiniettabile nelle reazioni più gravi).
Dermatite di interesse allergologico
-
Quali sono le principali dermatiti allergologiche?
Le principali dermatiti di interesse allergologico comprendono l’orticaria, le dermatiti allergiche da contatto, la dermatite atopica.
-
L'orticaria
L’orticaria è un’eruzione cutanea caratterizzata dalla comparsa di pomfi di svariate dimensioni, in genere pruriginosi, causati dalla liberazione di diversi mediatori chimici da parte di un particolare tipo di cellule chiamate mastociti; i pomfi si possono associare ad angioedema, cioè ad un “rigonfiamento” del tessuto sottocutaneo o delle mucose, che più frequentemente si manifesta a livello del labbro o delle palpebre, ma che può interessare anche molti altri distretti corporei.
Le orticarie possono essere acute o croniche: le orticarie acute possono essere provocate da allergia alimentare, da allergia a farmaci (es. farmaci antiinfiammatori, antibiotici, ma anche diversi altri farmaci), stimoli fisici (come la pressione sulla cute, il freddo, il contatto con l’acqua, l’esercizio fisico), oppure si possono manifestare in assenza di cause identificabili.
L’orticaria si definisce cronica quando persiste per più di sei settimane: in genere nell’orticaria cronica (più o meno associata ad angioedema) non si riesce ad identificare una causa responsabile, ed in tal caso è definita spontanea: l’orticaria cronica spontanea è spesso dovuta ad un processo di “autoallergia” o di autoimmunità e può associarsi ad altre situazioni di autoimmunità (es. tiroidite autoimmune); anche nell’orticaria cronica spontanea comunque vi sono spesso situazioni che possono scatenare il singolo episodio di riacutizzazione, ad esempio assunzione di farmaci antiinfiammatori (FANS) o l’ esercizio fisico.
La valutazione delle orticarie si basa su un’accurata anamnesi, volta a ricercare eventuali correlazioni tra gli episodi e l’esposizione a fattori scatenanti (es. farmaci, alimenti, ecc.), sull’eventuale esecuzione delle prove cutanee (prick-test) e, soprattutto nelle orticarie croniche spontanee, sull’esecuzione di esami ematochimici per la ricerca di eventuali correlazioni con patologie autoimmuni (es. anticorpi antitiroide) e per il dosaggio delle IgE totali, i cui valori possono indirizzare la scelta terapeutica.
Il trattamento delle orticarie si basa innanzitutto sull’eliminazione delle cause scatenanti quando queste sono identificabili, e poi sull’utilizzo di anti-istaminici per periodi più o meno lunghi di tempo, a seconda che l’orticaria sia acuta o cronica.
Per le orticarie acute si possono prendere in considerazione anche brevi cicli di terapia cortisonica, mentre per le orticarie croniche refrattarie al trattamento con anti-istaminici a dosaggi superiori alla monosomministrazione giornaliera, soprattutto nelle forme associate a valori elevati di IgE totali, si possono utilizzare farmaci biologici anti-IgE (omalizumab).
Infine, nelle orticaria croniche spontanee che non rispondono ai farmaci biologici anti-IgE si possono utilizzare farmaci immunosoppressori (ciclosporina).
-
Dermatiti allergiche da contatto
Le dermatiti allergiche da contatto sono dermatiti eczematose caratterizzate da eritema, vescicole e abrasioni e provocate dal contatto, in un soggetto allergico, con sostanze chimiche presenti in svariati prodotti per uso domestico o lavorativo, ad esempio oggetti metallici, cosmetici, creme, pomate, tinture per capelli, profumi, olii, coloranti e molti altri.
Per la diagnosi delle dermatiti allergiche da contatto si utilizzano i patch-test (test epicutanei):
i patch-test si eseguono applicando, sul dorso del Paziente, una serie di cerotti ognuno dei quali contiene le sostanze chimiche responsabili delle dermatite allergiche da contatto; tali cerotti vanno mantenuti per 48 ore, dopodichè si rimuovono e se in corrispondenza di un determinato allergene è comparsa un’area infiammata, eritematosa, con vescicole, significa che il patch-test è positivo per quella determinata sostanza, alla quale quindi il Paziente è allergico; viene fatta poi un’ulteriore “lettura” del dorso dopo altre 24 ore (quindi 72 ore dopo l’applicazione dei patch-test) perché non è infrequente la comparsa di positività “tardive”, successive cioè alla rimozione dei cerotti.
Talora, in caso di forte sospetto clinico ma negatività dei patch-test può essere utile procedere ad ulteriori “letture”, anche 96 ore e fino a 120 ore dopo l’applicazione dei cerotti.
Per l’esecuzione dei patch-test non bisogna avere assunto farmaci anti-istaminici o cortisonici nei 7 giorni precedenti l’esame.
Il trattamento delle dermatiti allergiche da contatto consiste innanzitutto nell’evitare l’esposizione alla sostanza responsabile; la cura delle lesioni cutanee si avvale poi di farmaci cortisonici (in genere topici) e anti-istaminici.
-
Dermatite atopica
La dermatite atopica è una malattia su base multifattoriale composta da fattori genetici, ambientali e immunologici.
I soggetti affetti da dermatite atopica hanno una barriera cutanea difettosa per cui entrano in contatto con sostanze normalmente tenute all’esterno.
Il cambiamento di stagione e lo stress psicofisico sono tra le maggiori cause di scatenamento della dermatite atopica.
È solo una minoranza dei pazienti interessati da dermatite atopica a risentire dell’assunzione di alcuni alimenti con il peggioramento delle chiazze eritematose, e il rapporto diretto di causa-effetto tra gli allergeni alimentari e la patologia è considerato piuttosto raro. Le diete ad eliminazione, soprattutto in età pediatrica, sono dunque ritenute inutili e potenzialmente dannose.
Sintomi della dermatite atopica :
La dermatite atopica si manifesta con chiazze rosse su cute secca e pruriginosa. Le chiazze possono essere ricoperte di vescicole, abrasioni, croste. Il prurito può essere più o meno intenso e tende a peggiorare durante la notte. Le manifestazioni della dermatite atopica sono molto simili ai segni e ai sintomi della dermatite allergica da contatto, è importante dunque confrontarsi esclusivamente con lo specialista dermatologo che, a seguito di una visita di controllo, saprà determinare la tipologia di dermatite in atto.
Diagnosi dermatite atopica :
Non esistono esami specifici per diagnosticare questa tipologia di dermatite. Per la diagnosi della dermatite atopica generalmente è necessaria l’osservazione dei sintomi durante una visita dermatologica. A volte la misura delle IgE totali può essere d’aiuto per distinguere le forme intrinseche da quelle estrinseche senza, tuttavia, un risvolto terapeutico significativo.
Trattamento dermatite atopica :
Per il trattamento delle forme lievi si utilizzano farmaci cortisonici topici, o alcuni immunomodulatori, sempre per uso locale, come il tacrolimus e il pimecrolimus. In forme di dermatite atopica che coinvolgono aree della cute molto estese si può ricorrere anche alla fototerapia. Per controllare il prurito e limitare il conseguente grattamento (che può provocare sia un ulteriore prurito, sia infezioni cutanee) si possono utilizzare antistaminici per via orale. Per il trattamento delle forme più severe di dermatite atopica si possono utilizzare steroidi sistemici o altri immunosoppressori come la ciclosporina o, nel caso questa sia controindicata o vi sia una risposta insoddisfacente, si possono utilizzare gli anticorpi monoclonali come dupilumab o tralokinumab. Nuove molecole specifiche inibenti le janus chinasi sono presto attese come alternativa terapeutica nelle forme più severe e resistenti (baricitinib, upadacitinib, etc).
Compila il modulo per contattarci
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo il più presto possibile.
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio. Riprova in un secondo momento.